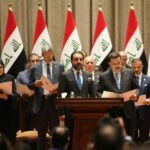Il 23 gennaio 2025 gli Houthi hanno liberato i venticinque membri della ciurma della nave mercantile MV Galaxy Leader, sequestrati nel novembre 2023 a seguito delle dichiarazioni di guerra da parte del gruppo non statale nei confronti di Israele e di tutte le navi in qualche modo legate ad esso. L’equipaggio della nave, sequestrata per la nazionalità israeliana del comproprietario della società madre associata ad essa, è stato rilasciato come diretta conseguenza dell’accordo per un cessate-il-fuoco a Gaza, raggiunto il 15 gennaio 2025 e reso operativo nei giorni seguenti. Gli Houthi hanno liberato la ciurma con il caveat di ritenersi garanti dell’accordo, e di limitare, ma non terminare completamente, gli attacchi, con un occhio fisso sul rispetto dei termini della tregua. Il rilascio è stato percepito con prudenza dal mondo mercantile europeo, che ancora non ha ripreso a pieno ritmo la rotta per il Mar Rosso, abbandonata dall’inizio degli attacchi in favore della più lunga ma sicura rotta intorno al Capo di Buona Speranza. Una nuova escalation tra Houthi, Stati Uniti ed Israele, a seguito della ripresa delle operazioni militari israeliane su Gaza a metà marzo 2025, ha reso ancora più lontana la prospettiva di un ritorno ad un utilizzo pre-crisi della rotta per il Mar Rosso.
Non confondere gli attacchi degli Houthi con attacchi di pirateria
Nell’ultimo anno, la parziale inagibilità del Mar Rosso ha creato forti reazioni nel mondo mercantile, diplomatico, e della difesa italiano, che ha serrato i ranghi per mostrarsi tra i più ferventi sostenitori dei principi di libertà di navigazione e sicurezza della navigazione, in linea con il diritto internazionale garantito dalla convenzione UNCLOS.
Dal punto di vista sia operativo che mediatico, l’approccio nei confronti degli attacchi Houthi nel Mar Rosso è stato affrontato in maniera simile a come sono stati affrontati gli attacchi di pirateria a largo del Corno d’Africa, attraverso l’Operazione EUNAVFOR Atalanta. Eppure, la situazione è molto diversa. Un atto di pirateria si caratterizza principalmente per il suo obiettivo, cioè il profitto privato ricavato dall’attacco. In questo caso, il fatto che gli attacchi siano stati lanciati da un attore non statale non deve distrarre dalla valenza prettamente politica e bellica di queste azioni. Pur trattandosi di un attore non-statale non riconosciuto dalla comunità internazionale, il gruppo Houthi controlla da oltre dieci anni la parte nord-occidentale del paese, inclusa la capitale Sanaa. Come attore politico con il potere de facto di governo su un territorio, gli Houthi hanno agito come uno stato dichiarando guerra contro Israele—includendo attacchi missilistici direttamente su territorio israeliano—ed hanno esplicitamente condizionato la fine dei loro attacchi nel Mar Rosso al raggiungimento di una tregua a Gaza. Il fatto che il gruppo sia sospettato di aver tratto comunque profitto da parte di quelle navi mercantili disposte a pagare per la propria sicurezza non riduce le operazioni a quelle di bande criminali, e il considerarle tali non lascia comprendere la natura della situazione così come la sua potenziale soluzione.
Andare oltre la sicurezza marittima
In questo contesto, è stato politicamente scivoloso da parte degli attori europei il far riferimento unicamente alla questione della sicurezza marittima e protezione della libertà di navigazione, trattandoli come principi oggettivi e ‘neutrali’ di diritto internazionale, senza soffermarsi abbastanza sul versante politico della questione. A poco è valso agli occhi dell’audience regionale cercare di distinguere l’operazione a guida europea Aspides dalla più offensiva Poseidon Archer a guida anglo-statunitense, sottolineando come nel caso europeo si tratti di una semplice operazione difensiva a garanzia della libertà di navigazione, non includendo attacchi su territorio yemenita contro le postazioni Houthi.
Infatti, le azioni a supporto della sicurezza marittima hanno generato frustrazione tra gli attori regionali verso quelli che sono spesso percepiti come doppi standard attuati dall’Occidente, ma anche tra quei partner, come le monarchie del Golfo, da tempo impegnati a gestire gli effetti della guerra in Yemen con poco supporto internazionale.
Il messaggio che è arrivato sulle sponde del Mar Rosso e fino al Golfo Persico è stato che l’Unione Europea ha cominciato a mostrare interesse per risolvere le cause che hanno portato agli attacchi Houthi solo nel momento in cui i propri interessi commerciali sono stati messi in pericolo, quando per anni—dal fallimento della conferenza per il dialogo nazionale in poi—il conflitto in Yemen è passato in secondo piano, senza un attivo impegno internazionale nei confronti di una soluzione di lungo periodo.
Risolvere i nodi del conflitto in Yemen
Ci sono alcuni nodi fondamentali che rendono la situazione nel Mar Rosso ancora precaria e che hanno contribuito ad esacerbare quella che per anni è stata definita la peggiore crisi umanitaria al mondo dovuta alla mancata risoluzione del conflitto in Yemen, soprattutto negli anni dell’intervento militare a guida saudita. Il principale nodo riguarda la riattivazione del processo di dialogo nazionale in Yemen, possibilmente sotto l’egida delle Nazioni Unite, che includa tutti gli attori e portatori di interessi coinvolti, dal governo internazionalmente riconosciuto, al movimento separatista del Sud, agli Houthi.
Di questo si è parlato a lungo tra gli addetti ai lavori dal 2011 in poi, e soprattutto dal 2014, quando gli Houthi hanno preso il controllo della capitale lasciando intendere di essere lì per restare, e di non poter continuare ad essere esclusi dai negoziati ufficiali. Solo attraverso un processo di riconciliazione inclusivo gli Houthi possono venire esautorati della loro portata rivoluzionaria, che facilmente può appigliarsi e sfruttare più ampi conflitti regionali per mostrarsi dal lato degli ‘oppressi’, ed evitare di doversi focalizzare sul rendere conto alla popolazione delle effettive capacità di governo del territorio.
Continuare il gioco ondivago della designazione/rimozione del gruppo dalla lista delle organizzazioni terroristiche, da parte degli Stati Uniti, rende ovviamente il nodo particolarmente difficile da sciogliere, ed è su questo punto che l’Italia potrebbe giocare una funzione attiva di facilitazione al dialogo, sfruttando il proprio auto-dichiarato interesse di svolgere un ruolo di ponte tra gli Stati Uniti dell’Amministrazione Trump, l’Europa, e il Mediterraneo Allargato. Per attuare questa strategia, è però necessario che l’Italia vada oltre la retorica della sicurezza marittima nell’area e prenda piena consapevolezza della dimensione politica della crisi e delle sue ramificazioni.
Questo articolo è stato scritto nell’ambito del progetto Rotte di distensione: sicurezza marittima e scenari di cooperazione attraverso il Mar Rosso, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Fondazione Compagnia di San Paolo.
Ricercatrice nel programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dell’Istituto Affari Internazionali. In parallelo, collabora come docente a contratto con la John Cabot University. I suoi interessi di ricerca includono la storia politica del Golfo Persico, storia diplomatica e coloniale, strategia marittima, politiche identitarie e teorie sul non allineamento.